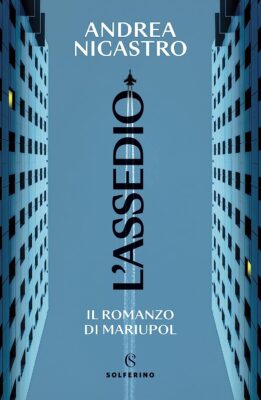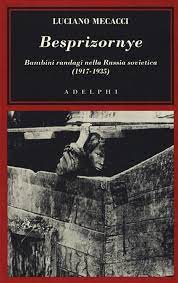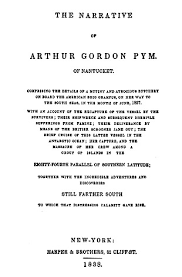della seconda guerra mondiale
di Mimmo Franzinelli, 2016,
Mondadori, Milano
È un libro che fa piangere e che fa infuriare. Non lascia uno stato di indifferenza.
–
In epoche arcaiche il disertore fu riferito a colui che guasta un ampio tratto di terra. Colui che devasta, che vuota l’area di abitatori. Ciò che riduce tutto in un deserto. La spogliazione.
In epoche riferite alla storia moderna il disertore è colui che lascia la bandiera, lo stendardo, l’insegna. Dal latino Desertare intensivo di Deserere abbandonare, composto della partic. DE che suppone il senso contrario a Serere, interesse, legare insieme, annodare, quasi dica, disunire, staccare.
–
Colui che scioglie la relazione sociale, il patto che rendeva un collettivo all’interno di unità di intenti, all’interno di valori comuni.
–
In un primo livello di analisi la diserzione, oggi, è riferita in modo irriflesso, quasi automatico, al singolo che, per deficienza morale, fisica e caratteriale rompe il patto e indirettamente indebolisce il gruppo a cui era in quel momento in piena interazione sociale.
–
È disertore quel colpevole che rende il deserto di un collettivo che combatte un nemico, qualcosa di altro da sé che si presenta in modo oppositivo. O loro o noi. La colpa è in primo luogo quella morale: è la vigliaccheria che induce alla ritrosia di affrontare la contesa. È la debolezza congenita e alimentata che nega il proprio ruolo per celarlo a fronte da quel contesto collettivo. Nel caso ritenuto più pericoloso è il traditore, colui che passa dall’altra parte della linea: il limes di guerra. Colui che non solo diserba le energie e le risorse che alimentano il collettivo, ma che addirittura sottraendole, e quindi anche contribuendo con le personali, indossa il ruolo del nemico. Della nemesi, quella che inverte il mio corso di vita e di significato che attribuisco al mondo: ciò che contraddice le mie azioni tendenti a uno scopo, e le mie convinzioni che rendono un ordine verso il mondo.
–
In questa visione il disertore è il male, colui che determina la possibilità del fallimento. Il disertore è la causa dell’indebolimento. Dalla sua persona parte il disfacimento, l’errore, la disfatta, cioè l’essicazione delle energie e delle qualità di questo fare: il fare che non riesce a legare il grano raccolto: appunto un disfare. Ciò che fa evaporare la mia irrigazione del buon terreno che offre vita e frutti: il diserbare, il disertare, che si compone nel rendere deserto, senza memoria e con conseguenze non volute la mia opera: l’azione con scopo, che si traduce nel perseguimento di obiettivi.
–
Certamente ciò è accaduto. Ma il disertore è solo questo? È solo questo vigliacco, traditore, di una morale viscida e sporca che innesta il processo di abbandono e di sconfitta, se parliamo di scontro di guerra diretto?
–
Non vi è forse da riflettere che anche il piano istituzionale, direttivo e statuale tradisca il collettivo che combatte e difende la comunità di riferimento? Che cambia quindi il significato della stessa bandiera con la quale si riconosce?
–
Non è possibile invece che il collettivo rimanendo immutato, improvvisamente si ritrova appellato come disertore perché la sua comunità di riferimento è presa da altri rappresentanti, oppure si frammenta in una serie di organismi antagonisti e che, quindi, agli occhi della nuova situazione è oggettivamente già un corpo estraneo?
–
Non si può concepire l’idea che i condottieri e coloro che forniscono gli obiettivi e gli scopi della composizione e della natura del collettivo che combatte, siano loro stessi a disertare? Ad esempio un Re guerriero che abbandona il proprio esercito, con i propri generali e lo stato maggiore (gli angeli che vegliano sulla morale), rende il collettivo senza la parola, l’acqua, il cibo, lo scopo, la direzione, la sostenibilità?
–
E ancora che questi nuovi organismi, invece di combattere l’originario orizzonte che sta oltre il Limes, per crescere, come masse tumorali, invece, aggrediscono il loro corpo di origine?
–
Sì: è possibile ed è accaduto: Il regno italico nella sua veste di dittatura fascista durante la seconda guerra mondiale.
–
Questo libro parla dei singoli disertori degli eserciti italici, e mostra indirettamente come furono perseguitati dai disertori primari del valor di patria secondo le loro stesse retoriche e come questi disertori originari si avventarono contro la propria popolazione di riferimento, dopo aver dichiarato la guerra a mezzo mondo.
–
Le vicende commoventi, strazianti, terribili di questi giovani e delle lor famiglie, mostra proprio da documenti dei primi disertori, di come questi ultimi con le loro condanne, fucilazioni, persecuzioni, ottusità, siano stati i primi a rendere un deserto di diritto, di vita, questo territorio italico, e di aver piantato malanimo, odio, vendetta, complesso di colpa, divisioni che durano ancora oggi riconfigurandosi come un’erba cattiva in nuove, sporche e viscide sterpaglie. Questi agricoltori del disonore con a capo un Re, la sua famiglia e corte, e i quadri di quel regime fascista, riprodotto poi in quell’orrore putrido che fu la Repubblica Sociale Italia: la serva sciocca dei nazisti che si concentrò a uccidere gli italiani stessi.
–
Vi sono state diverse forme di diserzione lungo la linea temporale degli avvenimenti e in concomitanza di eventi ben precisi che scandirono l’andamento apicale e poi di riflusso negli scontri armati.
–
Vi furono coloro che si rifiutarono di partire per il fronte nella Seconda guerra mondiale, non rientrarono da una licenza, fuggirono dalle lande gelate durante la Campagna di Russia, non vollero accettare la Repubblica sociale dopo l’8 settembre: migliaia di ragazzi – giovanissimi, anche se molti già padri di famiglia, spesso gli unici a portare a casa uno stipendio – finirono davanti ai Tribunali di guerra.
–
Mimmo Franzinelli rivisita questo complesso periodo storico per delineare la tipologia e le motivazioni dei disertori, analizzando le dinamiche repressive (Codice penale di guerra, Tribunali militari, modalità delle esecuzioni capitali) e ricostruendo le storie di tanti soldati, nei più disparati scenari, le cui drammatiche vicende sono sottratte all’oblio non solo grazie ai diari inediti ma anche al ricordo ancora attuale dei loro parenti.
–
“ […] Dalla «non belligeranza» (settembre 1939 – giugno 1940), quando due distinti flussi di soldati fuggono in Francia e Iugoslavia, alla prima fase dell’intervento italiano, quando disertori sono soprattutto i contadini e gli artigiani, poco disposti a morire in una guerra in cui non credono, sino all’estate 1943, quando, con lo sbarco in Sicilia, molti considerano persa la guerra, si battono di malavoglia e il fenomeno della diserzione aumenta a dismisura, acuendo la durezza della repressione, con «fucilazioni pedagogiche» dinanzi alle reclute. Con l’armistizio e la divisione dell’Italia in due governi (e sotto contrapposte occupazioni militari), la diserzione diventa il tarlo che rode l’impalcatura della Repubblica sociale e del Regno del Sud: i Tribunali militari lavorano a pieno ritmo e a Salò le fucilazioni si estendono anche a chi aiuta i «traditori», donne incluse. […]”
–
Questa storia, peraltro, non si conclude nel 1945: per oltre un ventennio la magistratura militare perseguirà gli ex disertori, inquisiti o imprigionati (e persino rinchiusi in manicomio) per essersi rifiutati di continuare a combattere.
–
103-104 “[…] Eppure, settori della popolazione diffidano del demiurgo e vedono come un incubo la prospettiva di indossare la divisa e marciare all’unisono. Tre mesi più tardi, un rapporto di polizia sullo stato d’animo dei romani è decisamente allarmistico: «La paura dello scoppio della guerra è ormai estesa e generale». In quei giorni, il capo della polizia, Arturo Bocchini, confida al ministro Ciano che «in caso di sommossa a carattere neutralista, carabinieri e agenti di polizia farebbero causa comune col popolo». In questo clima c’è chi, silenziosamente e dopo angosciate riflessioni, prepara l’espatrio clandestino, sentendosi straniero in patria. Nel momento in cui il Paese viene mobilitato per la prevedibile guerra, la diserzione costituisce il più clamoroso segnale di dissenso da parte dei giovani chiamati alle armi. Mussolini sa bene come la storia italiana sia segnata da diserzioni di massa: lo ricorda l’11 aprile 1940 a Ciano, indicando la guerra quale banco di prova del valore delle nazioni: «Per fare grande un popolo bisogna portarlo al combattimento, magari anche a calci in culo. Così farò io! Non dimentico che nel 1918 in Italia c’erano 540.000 disertori». In precedenza si era lamentato con il ministro degli Esteri a proposito dei legionari inviati in Spagna: «I casi di indisciplina sono più frequenti e cominciano, per la prima volta, le diserzioni». Il Tribunale militare del Corpo truppe volontarie italiane celebrò nel 1937-38 ben 260 processi per diserzione, 190 per disobbedienza e insubordinazione. Fughe dai reparti sono sempre in agguato, rileva il dittatore a metà settembre 1939, commentando con Claretta Petacci le difficoltà belliche anglo-francesi: «Sono già convinti di perdere… e intanto immagina che spirito alto… In Francia, poi, è un pianto. Pensa che non sanno più come arginare i disertori: decine di migliaia di disertori fuggono, non vogliono fare la guerra, capisci?».6 Mussolini, aggiornato sulla situazione interna inglese, ironizza sulle leggi «democratiche» che non infliggono la pena di morte ai disertori e consentono l’obiezione di coscienza […]”
–
I Tribunali militari di guerra puniscono la diserzione con la morte, per dissuadere i potenziali disertori, mettendoli davanti alle conseguenze della fuga dall’esercito. Dall’entrata in guerra sino all’armistizio, vengono condannati a morte circa 130 militari e circa 550 civili (41 in contumacia), in grande maggioranza nei Balcani.
–
Dati assai parziali, in quanto le statistiche non includono – se non saltuariamente – i procedimenti sommari da parte dei tribunali straordinari e ignorano le fucilazioni di partigiani catturati in combattimento e uccisi a freddo. I criteri di giudizio seguiti dai magistrati sono influenzati dalle contingenze belliche: blandi nel primo anno di combattimenti, s’inaspriscono nel 1942 e toccano nel 1943 picchi rivelatori del malessere aleggiante tra i soldati e dell’insicurezza dei comandanti.
–
Contro le sentenze, non è ammessa impugnazione; se pronunciate in territorio nazionale sono eseguite dopo ventiquattro ore; all’estero divengono immediatamente esecutive. I Tribunali di guerra più propensi a infliggere la pena capitale operano in Africa settentrionale e nei territori dell’ex Iugoslavia. Il pugno di ferro riguarda anzitutto i nativi accusati di «ribellione» e – dopo di loro – i disertori. Laddove si avvertono segnali di indisciplina e disgregazione, si usa il pugno di ferro. Il periodo di maggiore spietatezza coincide con l’addensarsi dell’odio popolare su Mussolini, dal dicembre 1942 al luglio 1943, quando la polizia politica non riesce più a contenere le proteste contro il dittatore: vi sono centinaia di arresti per il reato di «offese al Capo del Governo»; il duce è infatti definito affamatore del popolo (sono censiti 138 casi), responsabile della guerra (113), traditore della Patria (103), carnefice e brigante sanguinario (69), vigliacco e vile (63), colpevole di lutti e sofferenze (59).
–
Vi fu l’impunità di Stato dopo la fine della guerra, anche per l’amnistia che fu concessa a chi commise crimini di guerra, come i generali e alti ufficiali comminarono fucilazioni senza la parvenza di rispettare il proprio “aberrante” ordinamento giuridico militare. Il caso del generale Chatrian fu emblematico, perché si attivò per uccidere quanti più possibile, proprio nei giorni intorno all’8 settembre 1943, anche per soldati che compirono ritardi di uno o due giorni.
–
Questi personaggi aderirono alla Repubblica Italiana partecipando come parlamentari e in qualità di alti funzionari delle istituzioni. E questo generale come molti altri poi, furono i primi ad arrendersi al nemico. Loro che scrivevano ad ogni riga appesantendo anche la condanna con l’invettiva, per la quale: non si scappa di fronte al nemico, o si vince o si muore!
–
Loro che fecero uccidere giovani contadini che ritardarono di alcuni giorni il rientro dalla convalescenza perché feriti, o dalla licenza, per coltivare la terra della famiglia, perché la madre vedova con i figli piccoli non aveva di che sostentarsi, e a quei tempi senza il raccolto si crepava di fame e di malattie.
–
Lui, il grande Duce, che fu un disertore della prima guerra mondiale. Lui che fu il primo a cambiare idea su tutto: da anarchico, poi socialista. Poi repubblicano, poi pacifista, poi interventista, poi anticomunista, reazionario, baciapile, e alla fine scrivano dei nazisti.
–
E come dimenticare l’altro Lui in piccolo, il nostro disonore permanente: il maresciallo Graziani. Lui che fece stragi in Africa, terribili, che noi italiani continuiamo a dimenticare da decenni. Lui che fece scuola ai nazisti per l’efferatezza, divenendo poi subito lamentoso e spaventato quando le cose si posero al peggio e naturalmente si consegnò, in qualità di capo delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana, agli alleati, mica ai sovietici: chissà perché.
–
Non solo loro però, giovani italiani allo sbando, senza scarpe, munizioni, da mangiare, senza vestiti, arruolati a forza e poi fucilati e seviziati anche dalle camicie nere, magari gli ex vicini di casa. Ci deve far riflettere. Troppo comodo prendersela con quella fogna morale che furono le alte sfere, purtroppo per noi, e non lo vogliamo vedere che anche a livello popolare commettemmo atrocità.
–
La figura degli italiani “brava gente” di buon cuore, è successiva alla fine della guerra, e fu anche agevolata dagli Usa che per motivi strategici chiusero un occhio su di noi.
–
3538 – 3595 “[…] La nemesi della diserzione Soldato di leva della classe 1883 del Distretto di Forlì, il 27 marzo 1904 Benito Mussolini non si presenta al servizio militare e il successivo 30 aprile viene «dichiarato disertore per non aver risposto alla chiamata alle armi della sua classe». Denunciato al Tribunale militare di Bologna, il 2 agosto è condannato a un anno per diserzione semplice. La Svizzera rifiuta di estradarlo e gli concede asilo. In quel periodo il ventunenne rivoluzionario romagnolo raccomanda un mezzo infallibile per abbattere l’infame coartazione militarista: disertare! Egli, tuttavia, è un disertore dimezzato: a fine novembre cede alle insistenze materne e rimpatria, regolarizzando la sua posizione. Assegnato al 10° reggimento bersaglieri, in una caserma di punizione di Verona, beneficia dell’amnistia per la nascita del principe Umberto. Smobilitato nel settembre 1906, non ha mutato le proprie idee. Nell’ottobre 1911, con il repubblicano Pietro Nenni, capeggia violente manifestazioni contro la guerra di Libia, per bloccare le tradotte dei soldati: i due agitatori sono arrestati e condannati. Mussolini, liberato nell’aprile 1912 e divenuto direttore dell’«Avanti!», sino all’estate 1914 inneggia alla diserzione, «mezzo infallibile per annientare l’infame militarismo», arma micidiale contro la guerra voluta dalla borghesia internazionale. Di lì a poco salta la barricata e diviene interventista. Per i corsi e i ricorsi della storia, trent’anni più tardi combatterà i disertori, sabotatori della «sua» guerra. […]”
–
I bandi di arruolamento del maresciallo Rodolfo Graziani (ministro delle Forze armate) spingono i giovani sulle montagne, per istintiva autodifesa più che per valutazioni politiche, possedute da ben pochi. Ragazzi disorientati e confusi affluiscono ai distretti militari, per poi eclissarsi appena possibile. La renitenza, dilagante tra fine 1943 e inizio 1944, nell’incalzare degli eventi diviene resistenza. Nell’estate 1944 il rimpatrio delle quattro divisioni addestrate in Germania prelude alla diserzione di migliaia di militari, che se ne vanno alla spicciolata o incolonnati in lunghe file. Le bande dei patrioti ne traggono notevole beneficio, anche per l’armamento.
–
Dal 10 giugno 1940 al luglio 1943 il ministero della Guerra annota meticolosamente i reati militari e la loro repressione. Le vicende dell’armistizio disperderanno quel materiale statistico, di cui rimangono schemi settimanali lacunosi e il solo registro annuale del 1941, dal quale risultano per l’esercito circa 11.000 condannati, 3746 assolti e 45.000 processi ancora in corso, in aggiunta ai 3000 condannati dei rimanenti comparti militari.
–
Il 46,52 per cento dei reati riguarda la diserzione, che esplode nel corso del 1942 e dilaga nel 1943. Il dossier commissionato da Mussolini sui «processi definiti dall’11 giugno 1940 al 9 maggio 1943» con condanne superiori ai dieci anni, annovera per l’esercito 71.307 condanne e 95.082 assoluzioni. Si devono poi considerare le decine di migliaia di condanne sotto i dieci anni e le 11.000 assoluzioni. Dati comunque inferiori alla realtà, utili soprattutto a livello orientativo. Da notare che in quei 2 anni e 11 mesi le diserzioni crescono e gli altri reati diminuiscono.
–
I numeri, pur impressionanti, sono inferiori a quelli della Grande guerra, quando i tribunali militari aprirono oltre un milione di processi, infliggendo 40.028 condanne a morte, 746 delle quali eseguite, in aggiunta a 141 esecuzioni sommarie. Nel 98 per cento dei casi, le pene capitali riguardavano la diserzione.
–
Il fenomeno dei disertori ricomparve in Europa nell’autunno 1991 – sotto forma di obiezione di coscienza, renitenza e «assenze arbitrarie» dai reparti armati –, quando il governo della Serbia mobilitò i suoi cittadini nella prospettiva della guerra civile, etnica e religiosa che avrebbe presto dilaniato le regioni della ex Iugoslavia. Oggi le diserzioni si sviluppano sottotraccia in Siria, Ucraina, Libia, laddove i vari contendenti impongono arruolamenti coatti nelle zone da essi controllate. E la strage continua.