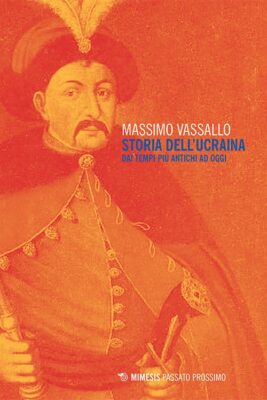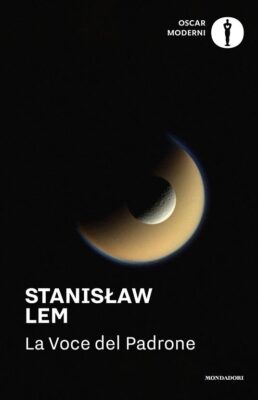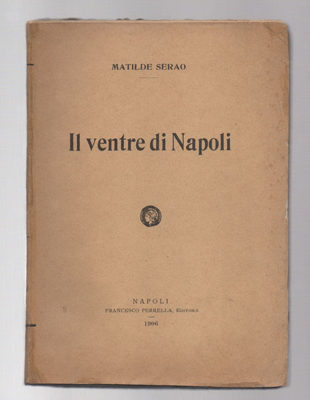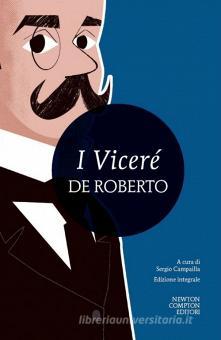La lettura di questo libro ci informa della nostra storia istituzionale e della nostra attuale vita quotidiana. Benché da gran parte dei lettori eventuali e della quasi totalità del popolo italico la “Cassa Depositi e Prestiti” sia intesa come un luogo, o un totem fumoso e lontano, in realtà ha a che fare con il nostro portafoglio, con l’orizzonte entro il quale scegliamo cosa e quanto possiamo spendere. L’ammontare di eventuali risparmi e la loro possibile allocazione.
–
In Italia vi è un problema strutturale di lungo periodo più accentuato rispetto ai paesi a noi vicini per il reddito, il livello di istruzione, e l’assetto tecnologico, rispetto a quelli dell’Unione Europea: un livello quasi totale di analfabetismo finanziario e monetario, anche per ciò che riguarda la gestione istituzionale del patrimonio pubblico e privato, per quanto piccolo o insignificante possa essere quest’ultimo.
–
Ripercorrendone l’operato dalla fondazione a oggi vediamo scorrere le vicende italiche: l’unificazione, le grandi trasformazioni economiche di fine Ottocento, la modernizzazione industriale dei primi del Novecento e gli effetti della Prima guerra mondiale, la crisi degli anni Trenta e le politiche per il Mezzogiorno del secondo dopoguerra. Oggi, a più di 170 anni dalla sua fondazione e dopo essere divenuta una Società per azioni, ha assunto pienamente un ruolo attivo per lo sviluppo delle infrastrutture e delle società ritenute “strategiche”, e non più solo come un erogatore passivo di risorse sul mandato del ministero del Tesoro e delle Finanze.
–
Ciò pone interrogativi sulla funzione storica di salvataggio di imprese anche decotte e di ciambella di sopravvivenza in occasione dei grandi sbandamenti finanziari e crisi di produzione, nonché strutturali del nostro paese, rispetto ad una presenza che è stata ritenuta soffocante per uno sviluppo imprenditoriale robusto e all’altezza dello scenario mondiale.
–
Per decenni l’Istituto fu utilizzato per gestire i debiti e i crediti cercando di mantenere l’assetto contabile e finanziario indipendente dai capitali stranieri, incanalando i risparmi di tutti in quello delle poste. Quintino Sella a suo tempo cercò di ampliare le attività della Cassa, oltre a quelle di erogare i prestiti agli enti locali, negli impieghi in titoli di Stato– di tipo fruttifero e infruttifero – con il ministero del Tesoro, in relazione al debito pubblico.
–
La “Cassa Depositi e Prestiti” contribuì alla costruzione di una base finanziaria nazionale. Tale processo fu opposto dalle banche rilevandone un possibile concorrente. E questa fu una tensione che ci portammo fino ai giorni nostri, riguardo i prestiti ai comuni e alle province.
Comportò un cambiamento nel modo di risparmiare dei cittadini per il disallineamento fra la raccolta postale e l’impiego di queste risorse, perché la raccolta postale ha tempi brevi e liquidità molto forte (tendenzialmente con rimborsi anticipati, effettuabili in ogni momento e senza vincoli), che si devono misurare con le condizioni di mercato, in termini di tassi e di rendimenti.
–
Nel 1876 vengono emessi 60.000 libretti di risparmio. In quell’anno, l’80% del denaro va ad alimentare i progetti pubblici del Paese reale e il 20% è destinato alla sottoscrizione dei titoli di Stato. La “Cassa Depositi e Prestiti”, a questo punto, ha una più cospicua forza finanziaria e una nuova centralità strategica. È il cuore dell’infrastruttura finanziaria italiana.
–
Durante la seconda guerra mondiale per quanto, soprattutto nei primi anni, continui a erogare mutui ai comuni e alle province – estremizza la sua funzione di polmone finanziario dello Stato.
–
Fino agli Sessanta vi fu un capitalismo manifatturiero privato proiettato sui mercati internazionali, reso debole, però, dall’inflazione nei bilanci e dalla lotta di classe nelle fabbriche. Questo modello basato sulla crescita della spesa pubblica e sui cittadini come “clientes”, è consentito dallo sviluppo internazionale, fino allo shock petrolifero di riduzione dell’offerta fra il 1973 e il 1974, con l’aumento del prezzo del greggio e, a catena, di tutte le materie prime.
Si ha la spinta inflazionistica e in concomitanza vi è lo sfaldamento del sistema di gestione monetaria di Bretton Woods.
–
Negli anni Settanta si hanno aumenti salariali non corrispondenti agli aumenti di produttività, una forte inflazione, la crescita del debito pubblico e la svalutazione della lira. Problemi strutturali che hanno portato conseguenze fino ai giorni nostri, ancora vive e pressanti.
–
Negli anni Settanta si hanno quindi l’inflazione e la recessione: la tempesta perfetta. Le monete europee perseguono un equilibrio basato su una parità di cambio, mitigata da un margine di fluttuazione dei loro valori. Nel 1973 l’Italia esce da questo meccanismo, con una svalutazione del 20%, la prima delle «svalutazioni competitive» che avrebbero segnato la storia nazionale nei successivi vent’anni.
–
Nel 1977 si prova a rimediare. Il ministro del Tesoro del terzo governo “Andreotti”, Stammati, opera un consolidamento dei debiti della finanza locale e nazionale attraverso un’emissione di titoli decennali del Tesoro a favore di “Cassa Depositi e Prestiti”. In linea di principio, da quell’istante comuni e province chiedono prestiti alla “Cassa Depositi e Prestiti” soltanto per gli investimenti e non a copertura dei debiti pregressi. Non è permessa più l’assunzione di nuovo personale e il nuovo indebitamento a breve termine formalmente viene vietato. Sulle urgenze, soltanto la Cassa può erogare mutui a breve scadenza. Questa chiarezza finanziaria non serve solo a evitare le micro-implosioni di province e di comuni, perché costituisce un tentativo di togliere opacità alla finanza pubblica.
–
Lo stesso Stammati, con la legge 468 del 1978, delinea un bilancio dello Stato sottoponibile alle verifiche e al controllo del Parlamento. Viene introdotto il bilancio annuale di cassa, oltre che quello di competenza. Il bilancio di competenza è esteso a più anni. La legge finanziaria diventa lo strumento di adeguamento della normativa finanziaria alla politica di bilancio, nella programmazione e nell’assestamento. Tutto questo pone le basi per una delle linee di fondo del funzionamento dell’Italia negli anni Ottanta: la determinazione annuale degli aggregati di finanza pubblica e la fissazione dei vincoli amministrativi da parte del governo.
–
Gli esiti legislativi promossi da Stammati, in realtà, confermano la centralizzazione prevalente delle fonti di finanziamento degli enti locali. Nel sistema di finanziamento degli enti locali, è appunto introdotto il principio di spesa storica quale criterio di riparto dei fondi statali tra gli stessi enti locali. Si tratta di un principio rigido perché cristallizza i differenziali di spesa corrente per abitante. Sembra bloccare l’esplosione della spesa pubblica locale. Si conferma, però, l’accentramento delle entrate (a fine anni Settanta il 95% della spesa regionale e il 65% della spesa locale sono sostenuti dai trasferimenti erariali) e allo stesso tempo si assiste a un irrobustimento della spesa pubblica locale, con il peso delle amministrazioni locali che, nel corso degli anni Settanta, aumenta sul totale delle amministrazioni pubbliche di oltre dieci punti, arrivando a sfiorare nel 1981 il 31%.
–
La “Cassa Depositi e Prestiti” è autorizzata a concedere mutui decennali ai comuni (garantiti dallo Stato) per portare sul lungo termine tutti i crediti che, a fine 1976, erano a breve termine. I comuni e le province diventano così debitori di lungo periodo della Cassa, che si assume l’onere di soddisfare i crediti delle banche. Lo stesso accade con i mutui che i comuni e le province non riescono a pagare. In generale Cassa fa, a un tasso del 15%, delle anticipazioni sui disavanzi che possono essere pari al massimo alla loro entità. Se, invece, l’ente pubblico è in pareggio nel 1976 ed è in disavanzo nel 1977, la Cassa eroga anticipazioni per il 70%. Diventano a carico dello Stato (e di Cassa) le rate dei mutui a pareggio di disavanzi economici dei bilanci degli enti locali e dei mutui contratti per il consolidamento dei debiti a breve termine. “Cassa Depositi e Prestiti” viene, poi, rimborsata dal Tesoro.
–
Il decreto legge 269/2003 diventa la legge 326/2003, con cui la Cassa si trasforma in una «vera e propria market unit, fuori dal perimetro delle amministrazioni pubbliche». La Cassa continua a svolgere il suo compito originario: il finanziamento di Stato, regioni, enti locali, enti pubblici, organismi di diritto pubblico mediante l’utilizzo del risparmio postale e di altra «provvista» che può essere garantita dallo Stato (la così detta «gestione separata 1», qualificata dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 quale «servizio di interesse economico generale», insieme al risparmio postale).
–
Così la Cassa svolge il suo ruolo più classico: prende il risparmio postale, su cui permane la garanzia dello Stato, e lo dà in prestito al settore pubblico perché faccia investimenti. Inoltre, sul piano giuridico e operativo, la Cassa può svolgere operazioni anche in regime di «gestione ordinaria» (tecnicamente definita «provvista non garantita dallo Stato») per finanziare – fra l’altro – opere e impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici. La gestione ordinaria viene sostenuta con l’emissione di strumenti finanziari – per esempio obbligazioni – ma appunto senza la garanzia dello Stato.
–
La chiusura del cerchio avviene anche a livello regolamentare e istituzionale: la Cassa è assimilata dalla Banca d’Italia a intermediario finanziario non bancario. Nella contabilità nazionale, dalla fine del 2006, la Cassa è classificata come una istituzione finanziaria monetaria, soggetta alla riserva obbligatoria, anche se non è assimilata a una banca: non è iscritta all’albo delle banche e non è soggetta al complesso delle regole prudenziali di vigilanza. La sua attività rientra in quella svolta dagli enti creditizi: la Cassa, assoggettata al regime di riserva obbligatoria prevista dalla regolamentazione della Banca centrale europea, diventa «controparte» nelle operazioni di politica monetaria di Francoforte, per esempio le operazioni di rifinanziamento.
–
La Cassa, diversamente dalle banche, è esclusa dalla vigilanza prudenziale fissata dalla Capital requirements directive. È quindi portata al di fuori dal debito pubblico. Poi, assolve al suo secondo compito ricevendo in dote dal ministero dell’Economia e delle Finanze i pacchetti azionari delle imprese post-pubbliche e, in cambio, apportando denaro fresco al ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) che, con questo, può abbattere ulteriormente il debito.
–
Ricordando che sono sempre soldi dei cittadini, nel 2003 viene acquistata dal Mef (Ministero Economia e Finanza) la prima tranche dell’Eni: il valore della transazione è di 5,3 miliardi di euro e corrisponde al 10% del capitale. Nello stesso anno “Cassa Depositi e Prestiti” diventa azionista di Enel e di Poste italiane. Acquisisce dal Mef il 10,35% di Enel per 3,1 miliardi di euro e nel 2009 sottoscrive un aumento di capitale per altri 3,1 miliardi arrivando al 17,36% del capitale. Nel 2003, rileva, sempre dal Mef, il 35% di Poste italiane per 2,5 miliardi di euro.
–
Nel 2004 vi è l’acquisto dalla allora Finmeccanica (oggi Leonardo) per 1,4 miliardi di euro di una partecipazione indiretta del 10,07% in STMicroelectronics NV, uno dei grandi gestori del settore della ricerca e della produzione dei semiconduttori e dell’alta tecnologia, attraverso l’acquisto del 30,44% della società di diritto olandese STMicroelectronics holding NV.
–
Nel 2005 rileva il 29,99% di Terna, la società della rete elettrica nazionale nata nel 1999, come primo effetto della liberalizzazione del mercato, in seno all’Enel, che poi l’aveva quotata nel 2004. L’acquisto vale 1,3 miliardi di euro. A condizioni radicalmente mutate, si verifica il meccanismo opposto di dieci anni prima con le privatizzazioni: negli anni Novanta le partecipazioni in capo alla Cassa sono state spostate, senza compensazioni, nel perimetro del Tesoro, che ha provveduto a trasformarle in Spa e poi a privatizzarle. Adesso, invece, quote significative dei gruppi di antica matrice Iri – ormai già riplasmati dalla membrana delle privatizzazioni – entrano nel perimetro della Cassa.
–
Intanto, dalle crisi finanziarie del 2008, a quelle dei fondi sovrani del 2011, fino ai giorni nostri con il Covid e le guerre che ci circondano, continua il declino economico e produttivo, di un paese vecchio, antimeritocratico, in crisi di Welfare, con una amministrazione sempre più pervasiva, ed inefficiente, la “Cassa Depositi e Prestiti” mantiene e sviluppa una ossatura solida che la rende un soggetto attivo di movimenti sui mercati secondari e primari, sugli investimenti e sulle acquisizioni.
–
Agisce da e con il settore pubblico. È un ente privato che sostiene e, in concomitanza, appare in concorrenza con le società privata. Attraverso le sue acquisizioni, si ha una idea dell’assetto presente e prossimo del paese. Ma, e qui vi è il nodo, tanto più il paese decade, la Cassa per converso acquisisce sempre più forza e incidenza sino al cuore infrastrutturale, economico e produttivo del paese. In un’ottica di breve periodo è un salvagente per i bilanci pubblici e anche per una minima sostenibilità del denaro di ognuno, ma nella visione strategica, sembra anche soffocare ogni altra attività che possa crescere e svilupparsi in ambito privato.
–
Proprio per la sua commistione opaca talvolta, incestuosa per tanti anni, ibrida e ambigua con il settore pubblico, e con l’agire politico sempre più debole nel riuscire nei suoi intenti, la Cassa incrementa e amplia il suo spazio di azione.
–
Tutto ciò apre un dibattito sul cuore dei nostri assetti istituzionali e dei rapporti di comunità che ognuno ha con l’altro.
–
La lettura di questo saggio che è quasi un romanzo storico per il modo agile e scorrevole di stesura, corredato da fonti bibliografiche corpose dagli archivi primari ufficiali dei soggetti coinvolti, è un’utile risorsa per approfondire cosa accade quando investiamo, depositiamo, risparmiamo e consumiamo, anche per la compravendita di oggetti quotidiani di facile consumo.
–
La “Cassa Depositi e Prestiti” è dentro i nostri bancomat e nei nostri portafogli. Fornisce le mappe delle scelte che compiamo credendo di esserne i soggetti autonomi, capaci di valutare in modo appropriato i nostri progetti di vita assicurativa, sanitaria, pensionistica e di investimento per noi e i nostri figli, o più in generale per le coorti generazionali future.
–
In un paese ove l’analfabetismo economico è drammatico in tutti i livelli, indipendentemente anche dal titolo di studio, sarebbe auspicabile riflettere in modo lento, pacato, e lontano dalle chiacchiere e dalle polemiche quotidiane, che, di fronte a questi temi, sembrano una matassa di fuochi fatui stagnanti in un’aria paludosa e mefitica.
–
Certamente le righe soprascritte in modo così polemico sono una provocazione, ma sarebbe il caso di conoscere chi è il nostro vicino di banco che ci accompagna ogni volta che prendiamo in mano il denaro in qualsiasi forma quest’ultimo sia.