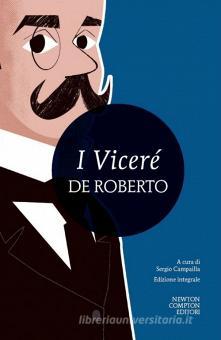– L’invenzione dell’amore, traduzione di Bruno Arpaia, Intrecci, 2018, Voland
La volontà di inventare vite irreali per cercare di amare. La narrazione bugiarda che tenta disperatamente di progettare il futuro. L’osservazione cinica della realtà che, muta, vuole esser contraddetta.
–
Il romanzo inizia con la narrazione in prima persona del personaggio principale che riflette anche dai discorsi degli altri protagonisti. Hanno quaranta anni, lavorano a Madrid e riflettono su di sé e sul passato e già dalle prime righe si intravede la memoria come costruzione di sé, come rammemorazione del passato che è una trama di verosimile, bugia, invenzione del presente, giudizio del futuro con l’intento di addomesticarlo alla propria singolare e contraddittoria visione che si vuole credere realtà.
–
La voce narrante riveste di tic il carattere del protagonista per orientare la sua biografia inventata. La investe delle sue induzioni, cerca di inserirli nel suo mondo, nella sua trama narrativa di significati per tracciare il suo tempo interiore. Lui è uno che osserva, contempla, guarda, dal terrazzo, mantenendo la distanza. E lo stesso vale per le donne, le guarda, immagina la loro compagnia, ma sterilizzata e a tempo. Ha paura della città e delle relazioni. Infatti gli piacciono le donne sposate. Non vuole essere martire o eroe.
–
173 Cerca di ricordare chi fosse Clara, morta per evitare un pedone con la macchina. Per telefono gli dicono che è stata una sua ex. Non la ricorda. Forse un fugace incontro dieci anni prima, verso i trenta anni e di come lei lo mollò e sposò uno che non sopportava. O no? Era un ricordo vero o una sua invenzione?
–
215 Al suo socio poi che lo vuole rimproverare per aver inviato un preventivo con i conti non conveniente per loro, racconta che deve andare a un funerale di Clara, e inventa di come lei guidasse male per evitare anche i gatti. Inventa una storia. Inventa storie su di sé. Moltiplica il suo vivere.
–
320 Il funerale lo descrive come un resoconto giornalistico, pieno di colori, impressioni, passando dal realismo dei luoghi al dipinto espressionista dei personaggi, e lui lì l’impostore, finge di stare con uno o con l’altro, come se conoscesse la defunta. Lui è integralmente e consapevolmente artefatto. Non è nel dubbio: è consapevole della falsità del suo essere lì nel presente di quei personaggi.
482 “[…] Gli uomini che vivono da soli, a partire da una certa età, quando hanno smesso di credere che la vita di coppia potrebbe essere piacevole o eccitante, spesso fanno poca vita sociale; le donne, comprese le rassegnate o quelle decise a restare single come l’amica che mi ha detto: “La mia metà inferiore ha smesso di interessarmi” mantengono contatti, escono, parlano di sé e delle altre amiche, hanno bisogno di carne, voce, intensità, così come gli uomini hanno bisogno di distanza, silenzio, indifferenza. Forse io non ho raggiunto quell’età o quella rassegnazione e perciò faccio in modo di combattere la tentazione di evitare la doccia se non devo uscire, di non radermi o non cambiarmi gli slip, di lasciare i piatti sporchi sul tavolo, di non chiamare nessuno per giorni. Anche se non ho molti amici e nemmeno sento la mancanza di una vita sociale più intensa, cerco di evitare quella sensazione di isolamento, di rapporto malato con schermi e marchingegni, con gli spazi chiusi, con il monotono ruminare della mia coscienza, con l’imbarazzante esistenza di chi non prova niente se non quando lo impone una serie tv. La terrazza è la mia salvezza, perché mentre sono lì, mangiando o leggendo, o pensando ai fatti miei, ho l’impressione di non stare soltanto ammazzando il tempo, ma di godermelo. Sei morto quando il piacere smette di attrarti, quando ormai pensi solo a evitare la noia e non ti importa se la tua vita è più assenza – di dolore, di passione, di entusiasmo – che contenuto. La peggior nemica della felicità non è il dolore, è la paura. Per essere veramente vivo devi essere disposto a pagare un prezzo per ciò che ottieni. Ed è lì che vacillo. Sto diventando pigro; mi costa pagare per ottenere e tendo ad accontentarmi di quello che arriva gratis, ovvero, di poca roba. […]”
–
737 La sorella Carina, racconta Clara come la vede, però dopo chiede che anche Samuel lo faccia. Sembra il racconto di Akira Kurosawa “Rashomon”: in cui tutti i personaggi mentono per salvare se stessi, cioè il proprio onore.
–
971 “[…] È noto che vogliamo che gli occhi dell’altro riflettano non ciò che siamo, bensì la persona che ci piacerebbe essere, anche se per questo dobbiamo sopportare la sensazione di inadeguatezza nel tentare di adattarci a quell’immagine ideale, o meglio a quella deformazione di noi stessi che ci favorisce. E poi, in genere, con il passar del tempo, finiamo per adattarci a ciò che siamo, smettiamo di fingere, rimproveriamo all’altro di aspettarsi da noi più di quanto possiamo dargli, dimenticando che era proprio quello che gli avevamo promesso. Soltanto le coppie che finiscono per riconoscere la frode e decidono di rinegoziare quello che ciascuno ha da offrire, riportandolo su un piano più realistico, hanno possibilità di durare con un minimo di felicità. Non ho quasi mai incontrato una di queste coppie. Al massimo, ne conosco alcune che, invece di iniziare una guerra di rimproveri, si abituano a utilizzare un tono ironico con cui danno a intendere che, sebbene fingano di credere nell’impostura dell’altro, sanno chi vive dietro la maschera, e s’impegnano a non strappargliela. […]”
–
1439 Carina e Samuel si avvicinano immaginando di riavere Clara, Carina per rivivere le storie di amore della sorella, Samuel per immaginare di stare con Clara, mai conosciuta. Tutti e due cercano di simulare qualcosa che credono vero, ma non lo è. Perché Samuel mai ha conosciuto Clara, e Carina non vuole in realtà interpretare la sorella, ma la sua stessa vita mancata. Mentono due volte e la seconda volta non se ne rendono conto. Risucchiati dalle loro stesse bugie. Samuel avverte il malinteso, ma non svela la sua impostura.
–
3081 C’è sempre un angolo oscuro, quella parte che perfino dopo molti anni continuerebbe a sorprenderci, forse a terrorizzarci se la scoprissimo. In qualche posto di noi stessi siamo soli, nessuno può venire con noi, ma non abbiamo motivo di rifiutare o di sottovalutare quel territorio in cui è possibile addentrarsi per mano a qualcuno, magari allargandolo, strappando alle erbacce zone in cui poter seminare
–
3130-39 Mi sento bene; sto bene. Eccitato. Allegro. Con Carina pronta ad ascoltarmi, con il suo corpo nudo accanto al mio. Così seria, Carina, in attesa che le racconti la verità sulla mia vita. Alzo lo sguardo verso quel cielo nero. Non vedo pipistrelli né, ovviamente, rondoni. Chiudo gli occhi e adesso sì, non posso più rimandare, inizio a raccontarle la storia di Samuel secondo Samuel.
–
ALLA FINE CERCA DI RACCONTARE LA VERITA’, ma futura con LEI; CON CARINA…. E il racconto prosegue.